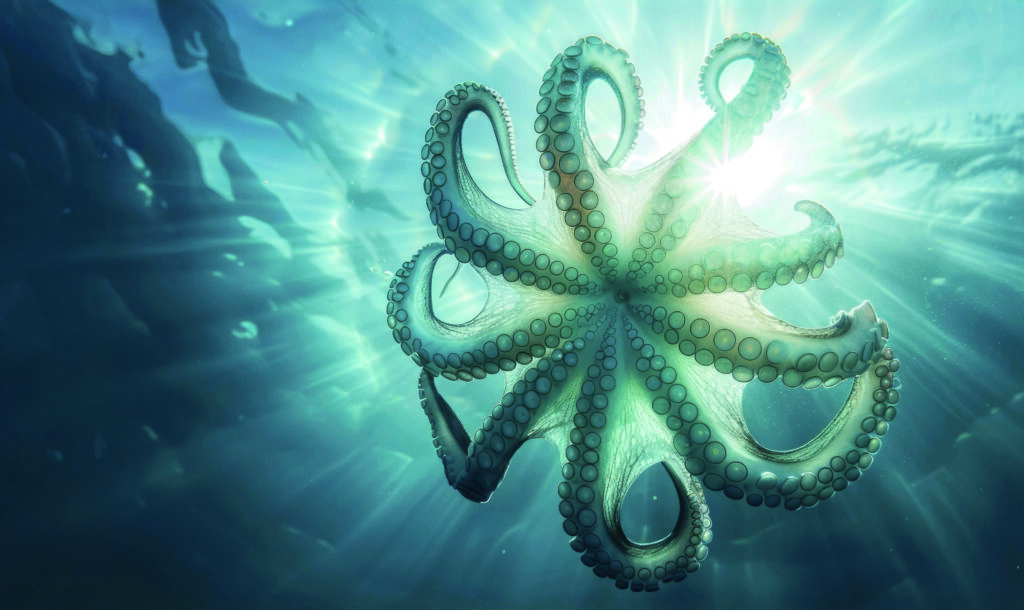Era una notte come tante in un laboratorio della costa californiana: provette allineate, incubatori in funzione, e un esperimento lasciato a maturare fino al mattino successivo. Quando la ricercatrice è tornata ha trovato qualcosa che fino a quel momento aveva resistito alle tecniche tradizionali: grandi quantità di un pigmento che nei polpi serve per cambiare aspetto. Quel risultato ha permesso di ottenere in vitro la xantommatina, un composto centrale per il mimetismo dei polpi, senza dover ricorrere agli animali. È il frutto del lavoro di un gruppo di biotecnologi guidato da scienziati legati alla Università della California a San Diego, che ha impiegato metodi di ingegneria genetica per spostare la produzione del pigmento da organismi marini a colture microbiche.
Come hanno adattato i batteri per produrre il pigmento
Il punto di partenza è stato riconoscere che la sintesi della xantommatina è complessa e richiede una catena di reazioni metaboliche non banali. Il team ha inserito nei batteri i geni necessari per ricostruire quel percorso e, soprattutto, ha progettato un sistema in cui la crescita delle cellule è legata alla produzione del pigmento, una strategia nota come biosintesi accoppiata alla crescita. In pratica, i microrganismi prosperano solo se attivano la via biosintetica che porta alla xantommatina: chi non la attiva resta svantaggiato e scompare nel corso della coltura.
Questa scelta tecnica riduce la necessità di selezioni complicate e mantiene stabile la produzione nel tempo. Le cellule geneticamente progettate generano anche sottoprodotti come l’acido formico, che i ricercatori hanno dovuto gestire per non compromettere le colture; un dettaglio che molti sottovalutano nei processi industriali di scala. Rispetto ai tentativi precedenti — che raggiungevano solo pochi milligrammi per litro — il nuovo approccio ha portato a rese di ordine superiore, rendendo praticabile lo studio su larga scala del ruolo del pigmento nel mimetismo.
Il lavoro in laboratorio ha richiesto iterazioni continue: ottimizzazione dei vettori genetici, controllo dei parametri di fermentazione e test analitici per confermare la struttura chimica del prodotto. Un aspetto operativo che emerge dalla sperimentazione è la pazienza necessaria nelle biotecnologie: spesso i risultati arrivano dopo notti di osservazione e correzioni incrementali. Questo metodo apre la strada non solo alla produzione del composto naturale, ma anche alla sintesi di analoghi modificati per studi funzionali.
Perché la xantommatina era così difficile e cosa cambia adesso?
La xantommatina è considerata un pigmento naturale raro per due motivi: la sua biosintesi coinvolge vie metaboliche poco comuni e la sua estrazione da tessuti animali è laboriosa e poco sostenibile. Nei cefalopodi questo pigmento partecipa alle dinamiche di colore attraverso cellule specializzate e interazioni con altri cromatofori e strutture ottiche; comprenderne il ruolo richiede quantità di materiale che finora erano impraticabili da ottenere.

La possibilità di produrre il pigmento in coltura microbiologica cambia il paradigma. Per la prima volta gli scienziati possono ottenere campioni sufficienti per analisi spettroscopiche, test su materiali e combinazioni con altri composti. Questo faciliterà studi su come la xantommatina interagisce con le fibre della pelle dei polpi e con superfici sintetiche, agevolando applicazioni in ingegneria dei materiali e in dispositivi mimetici. Un fenomeno che in molti notano solo d’inverno è la crescita dell’interesse industriale verso soluzioni bioispirate: qui si vede concretamente il passaggio dalla curiosità biologica alla possibile applicazione tecnica.
Oltre ai vantaggi applicativi, il nuovo metodo riduce la dipendenza dalla raccolta di organismi marini, un aspetto etico e pratico importante per i ricercatori. Allo stesso tempo, emergono nuove domande: come si comporterà il pigmento in condizioni di lunga durata, qual è la sua stabilità alla luce e al calore, e quali modifiche chimiche sono necessarie per adattarlo a usi commerciali. Le risposte richiederanno collaborationi con chimici, ingegneri e specialisti in scienze dei materiali, che già in diversi paesi europei e negli Stati Uniti mostrano interesse per progetti di biomimetica su scala maggiore.
Impatto potenziale, limiti e prossimi passi
La pubblicazione su Nature Biotechnology ha messo in evidenza non solo il risultato sperimentale, ma anche le implicazioni per la ricerca applicata. A livello pratico, la possibilità di ottenere fino a tre grammi per litro di coltura rende fattibile la produzione pilota del pigmento, benché restino sfide di scala e purificazione. La resa raggiunta è un salto rispetto ai milligrammi delle tecniche precedenti, ma passare da reattori di laboratorio a impianti industriali richiederà ottimizzazioni sui costi, sul controllo dei sottoprodotti e sulle condizioni di fermentazione.
Dal punto di vista normativo e di biosicurezza, l’uso di microrganismi modificati impone valutazioni specifiche, protocolli di contenimento e analisi di rischio ambientale; un aspetto che spesso sfugge a chi osserva dall’esterno. Inoltre, la stabilità del pigmento in applicazioni reali dovrà essere testata: esposizione a luce, umidità e solventi può alterarne le proprietà ottiche.
Le prossime mosse dichiarate dal team includono la collaborazioni con gruppi di Scripps Oceanography e centri di ingegneria dei materiali per testare il comportamento della xantommatina su superfici flessibili e sensori ottici. Un dettaglio che molti sottovalutano è che la traduzione di un risultato di laboratorio in un prodotto richiede tempo e iterazioni multiple: prototipi, prove su campo e verifiche di sicurezza. Intanto, il successo apre una strada concreta per studiare il mimetismo dei cefalopodi senza sfruttare gli animali e mette in luce come la biotecnologia possa trasformare scoperte naturali in risorse utili per ricerca e industria.
Fonte alanews >>> Scoperto il codice genetico che rende i polpi invisibili, ora prodotto in massa in laboratorio – 10 novembre 2025